Il consumo di alcol è profondamente radicato nella cultura italiana e spesso associato all’idea di convivialità e benessere. Nonostante ciò, la ricerca scientifica più recente invita a riconsiderare molte credenze diffuse, ponendo l’attenzione sui potenziali effetti nocivi dell’alcol anche a dosi moderate, soprattutto per quanto riguarda l’apparato digerente.
Per approfondire il tema, noi di Eccellenza Medica abbiamo intervistato il dottor Emanuele Tumino, gastroenterologo, Dirigente Medico di I Livello presso la U.O. C. di Endoscopia Digestiva dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, che ci ha aiutato a fare chiarezza sui reali effetti dell’alcol sullo stomaco, sull’intestino e, più in generale, sull’organismo umano. Con la competenza clinica che lo contraddistingue e chiarezza divulgativa, il dottor Tumino ci guida tra evidenze scientifiche, rischi sottovalutati e falsi miti ancora radicati nella cultura comune.
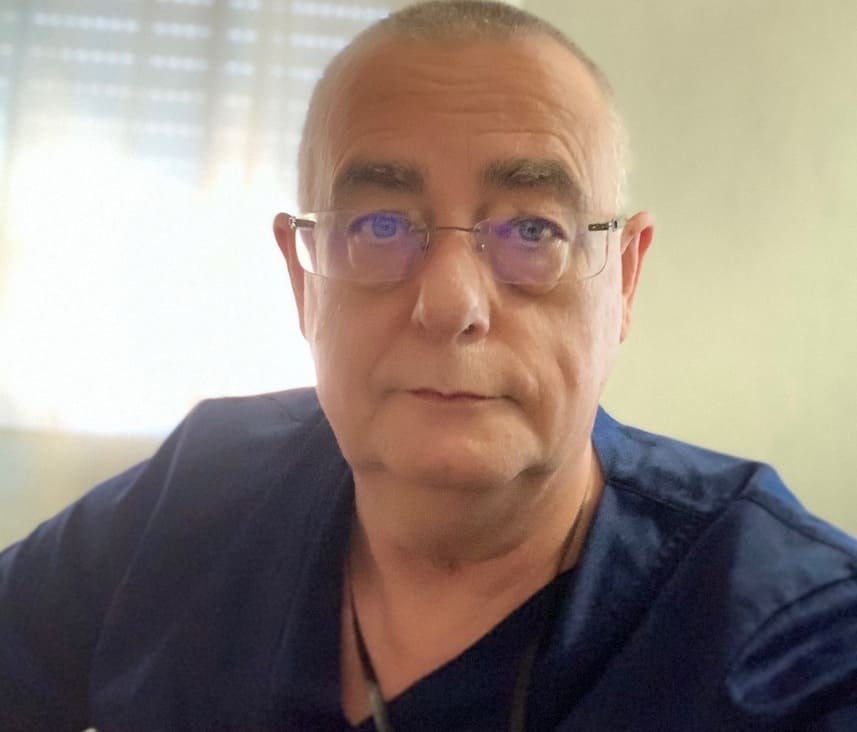
Dottor Tumino, si è soliti affermare che un bicchiere di vino rosso a pasto apporti benefici alla salute, persino all’apparato digerente. Alla luce della sua esperienza clinica e della letteratura più aggiornata, si può ancora ritenere fondato questo convincimento popolare?
"Per rispondere alla sua domanda dobbiamo partire da una informazione importante che riguarda l’alcol e ovviamente tutte le sostanze che lo contengono, ovvero cos’è l’alcol? L’alcol è una sostanza tossica che può dare dipendenza tant’è vero che per l’OMS è da considerarsi una droga. Detto ciò, se ne evince che meno se ne assume e meglio è".
Tralasciando per un istante l’attenzione, pur doverosa, che si riserva al fegato, le chiedo: quali sono, in termini fisiopatologici, gli effetti dell’alcol sullo stomaco e sull’intestino? Anche un consumo “moderato” può innescare processi dannosi nel tempo?
"L’alcol, una volta assunto, entra in contatto con l’esofago e, in base alla sua concentrazione, può creare dei problemi con il solo contatto. Una volta giunto nello stomaco, inizia una parte della sua degradazione mediante un enzima che si chiama alcol-deidrogenasi. Questo primo filtro gastrico è importante e ne condiziona l’assorbimento. Alcune popolazioni quali le asiatiche hanno una minore presenza dell’enzima e questo condiziona la minor capacità di “tollerare” l’alcol di queste persone. Anche nella donna è stato dimostrato una minore presenza di tale enzima. Nello stomaco l’alcol può avere un leggero effetto positivo perché funge da “mild irritant”, cioè una sostanza che stimola la produzione degli effetti difensivi della mucosa gastrica, un po' come piccole dosi di peperoncino rosso ovvero della sostanza contenuta che è la capsaicina. La restante parte dell’intestino risente poco dell’effetto dell’alcol perché l’assorbimento avviene tutto a monte. Ma altri organi diventano bersaglio di questa sostanza ed in particolare il pancreas con le pancreatiti ed il fegato con la cirrosi epatica. Naturalmente gli effetti tossici sono dose dipendente e legati molto all’uso che facciamo di questa sostanza nel contesto sociale".
Si parla con crescente insistenza del nesso tra alcol e patologie oncologiche dell’apparato digerente. Potrebbe aiutarci a chiarire quanto sia concreta la correlazione tra l’assunzione di alcol – anche in quantità non eccessive – e l’aumento del rischio tumorale?
"Partiamo dalla considerazione che è dimostrata la maggiore incidenza di tumori del cavo orale, esofago, fegato di persone che abusano di sostanze alcoliche per lunghi periodi della loro vita ovvero quelli che hanno sviluppato una dipendenza vera e propria e questo dimostrerebbe come i cambiamenti dello sviluppo cellulare in senso neoplastico può essere correlato all’effetto dell’alcol ma stiamo parlando di alte dosi; nelle persone che invece ne fanno un uso moderato non abbiamo informazioni sufficienti per poterlo asserire".
Numerosi pazienti affetti da gastrite cronica, reflusso gastroesofageo, o persino da malattie infiammatorie croniche intestinali, continuano a consumare alcol, talvolta in maniera abituale. Quali conseguenze cliniche può comportare questa abitudine, spesso sottovalutata?
"Se un uso di piccole quantità di alcol quotidiano è tollerato nei soggetti sani diverso è il discorso quando si parla di persone affette da patologie dell’apparato gastroenterico. In presenza di patologie croniche che possono degenerare, l’uso deve essere assolutamente vietato pena un peggioramento della malattia cronica, quali epatiti, pancreatiti o malattie infiammatorie croniche intestinali".
Dottore, vi è la diffusa convinzione che una maggiore tolleranza soggettiva all’alcol – ossia l’assenza di sintomi acuti anche dopo un consumo abituale – possa rappresentare una sorta di “immunità” dai suoi effetti nocivi. Dal suo punto di vista clinico, questa percezione è fondata o si tratta, piuttosto, di un’illusione che cela un rischio sottovalutato e potenzialmente insidioso?
"“Lui lo regge bene” è classicamente la definizione data a quelle persone che sono in grado di tollerare grandi quantità di sostanze alcoliche senza avere apparenti effetti negativi. Non è così, una maggiore capacità di tollerare l’alcol di fatto espone ad un maggior rischio di sviluppare dipendenza dallo stesso e in più subisce tutti gli effetti negativi amplificati dalla maggiore assunzione".
Alla luce dei dati scientifici più rigorosi, esistono oggi soglie di consumo alcolico che possano considerarsi effettivamente sicure? O, come alcuni sostengono, la miglior condotta resta quella della rinuncia, o quantomeno di un’estrema parsimonia?
"Negli ultimi anni questo è stato un tema molto dibattuto ovviamente perché tocca l’uso quotidiano di chi lo assume. Oggi una singola dose quotidiana sembra non avere effetti negativi sull’organismo sano e corrisponde a circa 40 gr di alcol al giorno. Per calcolare velocemente l’alcol che assumiamo possiamo usare un metodo approssimativo che consiste nel moltiplicare i gradi di una sostanza alcolica per 8 e così facendo otterremo i grammi di alcol contenuti in un litro di quella sostanza. Ad esempio, se assumo mezzo litro di birra che contiene 4 gradi (8x4=32gr) avremo assunto 16 grammi di alcol. Questo alcol assunto sarà metabolizzato dal nostro organismo ad una velocità di 100 mg/per Kg di massa corporea/ora".
In chiusura, dottor Tumino, vorrei chiederle una riflessione rivolta alle giovani generazioni, spesso esposte a un consumo regolare ma sottotraccia di alcolici. Quali messaggi ritiene opportuno trasmettere, in termini educativi, per accrescere la consapevolezza sugli effetti dell’alcol sul sistema digerente?
"L’uso delle sostanze alcoliche è fortemente legato alle tradizioni di una popolazione, in Italia ad esempio che è uno dei paesi con il maggior numero di aziende vinicole, l’uso quotidiano del vino interessa una grossa fetta della popolazione, diverso è invece è l’uso di alcolici tra i giovani che, sfruttando l’effetto disinibente di questa sostanza, ne fanno un uso che può diventare pericoloso. Cercare lo “sballo” da alcol è molto pericoloso anche se si usa l’unica droga legale che esiste in commercio. Quindi bisogna imparare a divertirsi non usando sostanze di qualsiasi natura".

